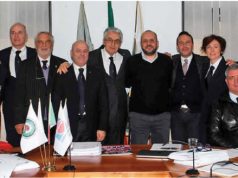Mettere a ferro e fuoco. In nessun’altra arma come nella freccia incendiaria questa espressione trova piena compiutezza, poiché essa unisce alla pericolosità dell’arma bianca da getto la forza devastante del fuoco. Una volta, questo strumento era in grado di seminare distruzione in interi villaggi, quando questi erano per lo più costruiti con paglia, legno e materiali altamente infiammabili. Si può ben immaginare, poi, la forza distruttiva di tali frecce se impiegate in battaglie navali contro vele di tela e scafi di legno stagionato e trattato con pece.
Durante la visione di film storici di ambientazione romana o medievale, non sono infrequenti scene con gragnuole di frecce infuocate; capita anche di imbattersi nelle preparazioni campali delle artiglierie nevrobalistiche, caricate con proietti incendiari.
A causa della mancanza di reperti che confermino le ricostruzioni, spesso tali film hanno sollevato delle perplessità. Ad esempio, è possibile sostenere che già intorno al III secolo d.C. esistessero realmente proiettili del genere? È plausibile che già all’epoca si fossero inventati miscugli incendiari di tale potenza?
Considerando che è assurdo sperare in un ritrovamento archeo-logico che ci fornisca qualche reperto tale da fugare ogni dubbio, l’unica strada è quella di rivolgersi alle fonti letterarie. Come scrive Flavio Russo nel primo dei suoi volumi “Techne”, editi da Rivista Militare e Finmeccanica, nei classici si trovano parecchie informazioni: sappiamo così delle frecce incendiarie con le cuspidi ad arpione appositamente forgiate per infiggersi nelle macchine nemiche o nelle strutture lignee cui si voleva dar fuoco. Sappiamo pure della “falarica” ed è Livio a lasciarci la descrizione di questa temibile arma. Si trattava di un giavellotto con un lungo ferro di circa 90 centimetri (pari a tre piedi) di lunghezza detto “verga”, completato con un breve manico in legno. La verga di ferro aveva una punta molto stretta e una sezione quadrata nella parte inferiore della barra che serviva per aumentare il peso dell’arma e quindi migliorarne ulteriormente la capacità di penetrazione. La punta era fatta in modo da poter contenere uno stoppaccio intriso di sostanze infiammabili come la pece.
Oltre al fatto di poter trapassare il corpo di un uomo, il giavellotto incendiario che colpiva l’armatura o lo scudo del nemico spargendo fiamme produceva un enorme effetto psicologico sui soldati nemici e contribuiva a diffondere paura tra le truppe avversarie. La falarica è stata usata anche come dispositivo incendiario durante gli assedi, non solo quando veniva gettata contro palizzate in legno al fine di provocare incendi e caos, ma anche perché la pece caduta sugli scudi ed indumenti dei soldati nemici costringeva l’assalitore a gettare armi e armature per non rimanere bruciato anch’esso.
Quanto ai miscugli incendiari, sappiamo che questa arma, secondo Ammiano Marcellino, non poteva essere spenta se non coprendola di terra. In una raccolta del X-XII secolo di antiche ricette per pirofori chiaramente di epoca romana se non ellenistica, intitolata “Mappae Clavicola”, si parla di un cocktail micidiale composto da zolfo, olio di trementina, resine e nafta. Nel testo sono descritte: “Col nome di frecce porta fuoco delle frecce vuote la cui cavità interna era riempita con un miscuglio di nafta pece, zolfo, sale e stoppa: spesse volte la tubolata era coperta di rame per impedire che la composizione incendiaria si consumasse prima che la freccia fosse giunta a destinazione.
I vasi di fuoco erano recipienti di coccio (vasa fictilia) riempiti di stoppa imbevuta di un miscuglio di bitume liquido, di pece e di zolfo, e muniti di una miccia solforata. Venivano scagliati con apposite macchine; al momento della caduta il vaso si rompeva e la composizione incendiaria andava a contatto dell’oggetto colpito. Di questa specie di proiettili fanno parola Appiano: “Sulphur et picem in fasis fundis emittebant”; Dionisio di Alicarnasso: “Bitumane et pice fervida vasa replenta fundis inferentes” e Frontino: “Amphoras pice et teda plena iaculatus est”. Il loro uso fu generale e grande specialmente negli attacchi marittimi di Demetrio contro Rodi (304 a.C.) e nelle battaglie navali che avvennero durante la seconda guerra punica. Fra i tanti proiettili incendiari si lanciavano anche delle pietre porose dopo averne riempito le cavità con materie infiammabili e avervi appiccato il fuoco. •
Il ricostruttore di macchine belliche romane
Da oltre un decennio un gruppo di tecnici e di artigiani presieduto dall’ingegner Flavio Russo si occupa della ricostruzione delle antiche macchine ellenistico-romane, in particolare delle artiglierie che armavano le legioni e le loro innumerevoli fortificazioni. A coordinarli provvede personalmente Russo, sia dal punto di vista teorico, come storico militare e come esperto di armi e congegni bellici, sia dal punto di vista tecnico, come ingegnere con oltre una trentina di anni di cantiere alle spalle.
L’attività di ricostruzione di antiche macchine belliche, o comunque tecnologiche, di epoca romana potrebbe apparentemente sembrare un hobby per persone dotate di risorse economiche e tempo libero: la realtà tuttavia è ben diversa.
Questa singolare produzione è un lavoro a tutti gli effetti e come tale obbedisce alle normali leggi di costruzione e di mercato, con in più una serie di adempimenti di natura culturale drasticamente assenti nella altre attività.
Ogni ricostruzione, infatti, deve essere supportata da un preciso riferimento storico-archeologico e sottostare a tre criteri imprescindibili: deve essere documentata nelle fonti scritte, deve essere confermata da reperti archeologici e deve vantare almeno una qualche menzione iconografica.
Nessuna deroga è consentita per l’attendibilità della ricostruzione.
La produzione si occupa principalmente della ricostruzione delle antiche macchine belliche di epoca ellenistico-romana, ed in particolare delle artiglierie elastiche. Queste costituirono i primi congegni dotati di un apparato motore e di un accumulatore energetico, con comando differito nel tempo a discrezione del servente. Lo studio concreto di queste remote macchine e delle loro effettive connotazioni rientra nella cosiddetta “archeologia sperimentale” che ha tra le sue finalità la riproduzione degli antichi manufatti, allo scopo di verificarne le potenzialità, così da fornire quelle informazioni che la ricerca sul campo non è sempre in grado di restituire. Anche la più attenta delle indagini sistematiche, infatti, deve misurarsi con la rarità dei reperti, più o meno danneggiati, e con l’avulsione degli stessi dal contesto originario. Senza contare che la loro preziosità ne impedisce spesso qualsiasi vaglio conoscitivo, al di là della mera fotografia. Ne consegue che le deduzioni materiali fin qui acquisite siano per lo più esiti dell’archeologia sperimentale, ottenuti secondo alcuni rigidi criteri.
Il primo prescrive che materiali e tecniche impiegati siano perfettamente identici a quelli in uso nell’epoca in esame; il secondo che, a loro volta, le nozioni tecnico-scientifiche fossero allora note; il terzo che le fonti, scritte e iconografiche, provino con sicurezza l’esistenza del manufatto in studio.
AC
La freccia che accese il tripode olimpico
In tempi recenti, una freccia incendiaria è stata utilizzata per uno degli spettacoli di inizio delle Olimpiadi più belli di sempre, quello di Barcellona 1992. In questa occasione, la Cerimonia d’apertura, svoltasi nello stadio olimpico del Montjuic, venne intesa come un inno al Mar Mediterraneo e al mito della fondazione di Barcellona. Il momento più emozionante fu appunto l’accensione del tripode, con il cestista Juan San Epifanio, che passò il fuoco all’arciere paralimpico Antonio Rebollo (l’arciere paralimpico spagnolo di 36 anni medagliato a Los Angeles e Seoul) il quale a sua volta scoccò la freccia che innescò il meccanismo di accensione del fuoco, mai così spettacolare fino ad allora e ancora oggi tra i più belli di sempre in tutta la storia delle Olimpiadi.
La freccia ardente doveva compiere una ben precisa traiettoria che prevedeva il passaggio ad almeno un metro sopra il braciere per poi proseguire e ricadere fuori dallo stadio di Montjuic. Perché la fiamma olimpica si accendesse al passaggio della freccia, era necessario far uscire il gas con una certa forza: anche se l’arciere Antonio Rebollo avesse sbagliato di poco la mira, il tripode doveva prendere fuoco. E infatti, mentre Rebollo prendeva la mira, dal braciere è cominciato ad uscire, invisibile, un getto di gas alto alcuni metri. Un po’ come capita con l’accensione dei fornelli di cucina quando la fiamma si innesca prima ancora di avvicinare il fiammifero proprio perché il gas ha saturato l’area intorno al fornello. Il meccanismo di questa accensione era stato studiato da tempo e da circa due mesi era stato descritto nei minimi particolari sui documenti olimpici. Rebollo da due mesi provava questo esercizio e fino all’ultimo momento non era certo di essere lui il prescelto. Gli organizzatori lo tenevano in concorrenza con il giovane arciere catalano Joan Bozo e solo verso l’imbrunire di sabato, mentre tutti e due attendevano in camerini separati, venne comunicato a Rebollo che toccava a lui stupire il mondo intero con quel tiro. L’arciere aveva fatto più di mille prove e aveva seguito una cura specifica anti-stress. Una televisione tirò fuori una polemica, contestando il fatto che al momento dell’accensione, le tv di stato che riprendevano il momento avevano tolto l’inquadratura per non fare vedere che la freccia finiva fuori dal braciere. Tuttavia questo non era affatto voluto. Ciò che si era preparato per lungo tempo era solo che la freccia attraversasse il flusso di gas per innescarlo, non che finisse anch’essa dentro al tripode, tanto è vero che l’area sottostante era stata transennata ed era quella sera tenuta sotto controllo dalla polizia proprio per evitare che la freccia ancora ardente potesse fare dei danni.
AC